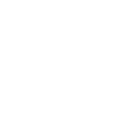La spiritualità San Riccardo
Pampuri
IV parte
Spiritualità lieta
San
Riccardo, nella sua vita e nella sua attività, manifestava anche questo aspetto
lieto e gioioso dello spirito umano, e vera dimensione di una fede cristiana
accolta con gratitudine e vissuta con coerenza e fedeltà; una gioia che egli
attinge soprattutto dall’incontro con Cristo nell’Eucaristia, come emerge dalla
lettera che scrive alla sorella suora dopo aver partecipato al Congresso
Eucaristico nazionale a Genova: «Dal gaudio di questi felici momenti di
amore eucaristico ben si può comprendere, per quanto lo permetta la nostra
mente limitata, qual gaudio infinito di perfetta felicità ci compenetrerà nella
beatifica visione diretta di Dio in Cielo» (6 ottobre 1923). Proprio il
pensare a questa prospettiva di gioia futura ed infinita, che già si poteva
pregustare nell’esistenza terrena, rendeva gioioso il suo vivere e agire.
Fin
da giovane il nostro Santo aveva un atteggiamento e un comportamento sempre
raccolto, composto, riguardoso; un po’ timido, ma che già viveva le virtù
dell’umiltà e della semplicità, della mitezza e della serenità[1];
colpiva per la sua limpidezza e chiarezza della sua intelligenza, unita ad una semplicità
veramente grande e ad una modestia veramente rara; era mite, ma inflessibile
nell’esercizio dei suoi doveri[2];
manieroso, sempre calmo e sempre uguale a se stesso, la cui presenza edificava[3].
Un suo collega medico testimonia: «Di
carattere dolce, ma sempre cordialmente rettilineo, fu severo ma sereno
studente tra di noi, che pur partecipando alle nostre inevitabili gazzarre
goliardiche, sapeva stare allo scherzo concesso dai limiti dell’onesto e del
gioviale, con spirito e comprensione, sapeva ritirarsi intelligentemente e con
umiltà tranquilla nei momenti cruciali, e sapeva essere fedele amico nei casi
contrari e dolorosi»[4].
Una
spiritualità che, anche durante il periodo della guerra, mentre si trovava a
Malonno, in Val Camonica, in un piccolo ospedale da campo, lo porta a scrivere
alla sorella: «Io godo sempre buona
salute, ed ora mi trovo in una posizione così comoda e lontana da ogni pericolo
che non potrei desiderare di meglio. Un paesetto tranquillo di una
graziosissima valle dove tutto è bello e dove ogni cosa, dai verdi e folti
castagneti lungo i fianchi dei monti, ai paesetti appesi agli erti pendii sotto
la dolce protezione di bianche chiesette, (…) tutto ci parla della potenza
infinita del Divin Creatore, della Sua infinita bontà» (20 agosto 1918). A
ricordare che, un tale spirito, aiuta a valutare la realtà con obiettività e
serenità, senza perdersi in lamentele o pessimismo, ma a godere, a vivere
pienamente il presente e trovare anche nelle esperienze avverse e difficili
realtà o pensieri che motivano l’agire e aprono il cuore alla speranza,
affidando il tutto al Creatore.
Dal
modo di vivere una spiritualità lieta, possiamo comprendere che il Santo non
era una persona distaccata, seriosa o altezzosa, che disdegnava il
divertimento, la compagnia e le occasioni gioviali da vivere con gli amici,
purché non si oltrepassassero certi limiti. Sono, infatti, diverse le testimonianze
che ricordano anche il suo atteggiamento ilare e gioioso, a tratti scherzoso,
come quando a Pavia, durante il corso Battaglione Studenti Universitari, salito
sul tram, dal quale il tramviere era sceso, lui stesso guidò il mezzo per un
certo tratto[5].
Atteggiamenti
che ricordano positivamente anche i famigliari, come il fratello Agostino, il
quale afferma che, essendo fin da bambino capace ed industrioso, sapeva fare
tutto e anche da medico faceva giocattoli perfetti per i nipotini[6]; o
la sorella Margherita che ricorda: «Mio
fratello era sempre sorridente e canterellava, anche quand’era stanco della
visite fatte in giro per la condotta. Non lo vidi mai impazientito. Non si
lamentava neppure quando, allorché tornava dalle visite, non gli facevo trovare
pronto il pranzo o la cena»[7].
La
sorella suora, poi, rivelando la vera fonte della sua gioia, afferma che «mi ripeteva sempre che egli si sentiva una
gioia così grande ai piedi di Gesù Sacramento che ci sarebbe stato delle
giornate intere»[8];
mentre il nostro Santo, dopo che la sorella suora ebbe trascorso con lui alcuni
giorni di vacanza a Morimondo, prima di tornare in Egitto, scrive: «Anch’io ricordo con tanta commozione quei
felici momenti passati in tua compagnia ai piedi di Gesù Eucaristico, e tale
dolce ricordo mi fa tanto bene e mi aiuta a ravvivare un po’ di più l’intrepido
affetto per il Divino Amico, per lo Sposo celeste dell’anima nostra» (19
gennaio 1926).
Il
suo maestro di Noviziato afferma che «nel
passeggio e nelle ricreazioni era sempre lui che sapeva divertire senza mai
offendere la carità»[9],
mentre un suo confratello ricorda come si prestasse volentieri e con amabilità
ai loro scherzi[10].
D’altronde lo stesso Santo, pochi giorni dopo la Professione Religiosa, scrive
in una lettera: «Quale grave torto
faremmo a N. Signore se dovessimo servirLo con una spanna di broncio” (27
ottobre 1928).
San
Riccardo, in una lettera alla sorella, ricorda anche la fonte, la sorgente, il
motivo di questa gioia interiore che animava la sua esistenza, che diventa in
invito ad imitare il suo esempio: «Ritorniamo
nell’atmosfera fulgida e serena di Gesù e di Maria, ove l’animo nostro respira
un’aria balsamica, e il cuore si dilata nell’amor di Dio, del nostro Sommo Bene
e nella generosa carità del prossimo. (…) Oh come gode il nostro Cuore, come si
trova felice quando, dimentico e libero delle piccole miserie dell’amor proprio,
ama generosamente tutto il suo prossimo per amor del suo Dio, e serve e
ubbidisce ed ama il suo Dio nel suo prossimo. (…) Trionfando in noi l’amore e
la fiducia piena in Gesù e Maria e la santa carità del prossimo, fuggono come
nebbie malefiche dal nostro animo tristezza, sospetti e scoraggiamenti, e
tutto, anche le prove e le aridità e le croci, resta come soffuso di una luce
nuova, luce soprannaturale nella quale l’anima nostra trova finalmente il suo
conforto, la sua pace, la sua letizia» (24 giugno 1929).
Paolo
VI, nell’Esortazione Apostolica sulla gioia cristiana, Gaudete in Domino
(promulgata in occasione della celebrazione dell’Anno Santo del 1975), offre
un’adeguata e illuminata sintesi della spiritualità lieta che visse il nostro
Santo, ma che diventa invito per ogni cristiano, anche per ciascuno di noi, a
vivere e testimoniare la gioia che viene dall’incontro con Cristo: «Nella
vita dei figli della Chiesa, questa partecipazione alla gioia del Signore non
si può dissociare dalla celebrazione del mistero eucaristico, ov’essi
sono nutriti e dissetati dal suo Corpo e dal suo Sangue. Di fatto, in tal modo
sostenuti, come dei viandanti sulla strada dell’eternità, essi già ricevono
sacramentalmente le primizie della gioia escatologica. Collocata in una
prospettiva simile, la gioia ampia e profonda, che fin da quaggiù si diffonde
nel cuore dei veri fedeli, non può che apparire “diffusiva di sé”, proprio come
la vita e l’amore, di cui essa è un sintomo felice. Essa risulta da una
comunione umano-divina, e aspira a una comunione sempre più universale. In
nessun modo potrebbe indurre colui che la gusta ad una qualche attitudine di
ripiegamento su di sé, Essa dà al cuore un’apertura cattolica sul mondo degli
uomini, mentre gli fa sentire, come una ferita, la nostalgia dei beni eterni» (cap. IV).
Spiritualità mariana
«Affidandosi
filialmente a Maria, il cristiano, come l’apostolo Giovanni, accoglie “fra le
sue cose proprie” la Madre di Cristo e la introduce in tutto lo
spazio della propria vita interiore, cioè nel suo “io” umano e cristiano. (…)
Questo rapporto filiale, questo affidarsi di un figlio alla madre non solo ha
il suo inizio in Cristo, ma si può dire che in definitiva sia orientato verso
di Lui. Si può dire che Maria continui a ripetere a tutti le stesse parole, che
disse a Cana di Galilea: “Fate quello che egli vi dirà”» (Redemptoris
Mater, nn. 45s).
Questa
espressione di San Giovanni Paolo II ben si addice a presentare l’aspetto
mariano della spiritualità di san Riccardo Pampuri: egli, orfano della mamma da
piccolo, educato nella fede, soprattutto con l’esempio, dagli zii di Torrino,
accoglie nella sua giovane vita una nuova Madre, alla quale riserverà un
affetto figliale, devoto, sincero e costante, certo della sua materna e premurosa
vicinanza, protezione e assistenza, senza, però, dimenticare o mettere in
secondo piano la sua fede in Cristo, il suo ardente amore per il Cuore di Gesù.
Nella
sua vita, particolare “posto” aveva la recita del Santo Rosario, una pratica
alla quale era fedelissimo sia in famiglia (e poi in comunità), sia
individualmente, durante spostamenti o viaggi o attese; la corona scorreva fra
le sue mani in modo incessante, consapevole che questa preghiera, sempre
proposta dalla Chiesa, era prezioso strumento per una preghiera di lode, di
supplica, di intercessione. Del Rosario san Riccardo comprendeva la sua vera
dimensione contemplativa, senza la quale, come ricorderà papa Paolo VI nell’Esortazione
Apostolica Marialis Cultus, «il Rosario è corpo senza anima, e la sua recita
rischia di divenire meccanica ripetizione di formule. (…) Per sua natura la
recita del Rosario esige un ritmo tranquillo e quasi un indugio pensoso, che
favoriscano all’orante la meditazione dei misteri della vita del Signore, visti
attraverso il cuore di colei che al Signore fu più vicina, e ne dischiudano le
insondabili ricchezze» (n. 47).
Una
spiritualità mariana che diventava anche richiesta di preghiera, soprattutto
quando scrive alla sorella suora: «Intanto
ricordami molto in questi ultimi giorni del bel mese della nostra Madre Celeste
affinché nel prossimo mese del S. Cuore di Gesù voglia esaudire la bella
preghiera dello Stabat Mater: Fac ut ardeat cor meum in amando Christum Deum,
ut sibi complaceam»
(17 maggio 1924). Una spiritualità che diventa anche ricordo della cara mamma
defunta, che, con la sua preghiera, può ancora accompagnare i suoi figli: «Voglia la Madonna, la nostra amatissima
Madre celeste, anche per intercessione della nostra buona e santa madre defunta,
concederci la grazia di una sempre più abbondante rugiada di grazie celesti e
una sempre più pronta e piena corrispondenza onde, reso più fecondo il nostro
povero cuore, abbiano da fiorirvi in questo bel mese di maggio, qualcuno almeno
dei fiori a Lei più cari: dal giglio purissimo alla tanto fragrante e graziosa
viola della modestia e della umiltà, all’ardente rosa della carità» (2
maggio 1926).
In
un’altra lettera esprime la gioia di aver potuto recarsi presso il santuario
mariano di Lourdes e altri luoghi santi della Francia: «Io ho avuto la insperata e specialissima grazia di andare un mese fa a
Lourdes con la zia Maria: in viaggio ci siamo fermati a Paray-le-Monial nella
Chiesetta ove Gesù apparve a S. Margherita Maria Alacoque, e a Ars nella Chiesa
del Beato Curato Vianney» (28 luglio 1924). Si racconta che tornato dal
pellegrinaggio, la sorella Rita gli chiese: «Ti è piaciuto? È bello il luogo?»;
Erminio le rispose: «Sì. Il Santuario è bello, v’era tanta gente, ma ciò
che più conta è la fede che ho visto in quel luogo benedetto».
Nell’inviare
alla sorella suora la fotografia “ufficiale” del suo nuovo stato di vita con
l’abito da religioso, seduto accanto ad un tavolino rotondo dove è appoggiato
un libro, che tiene nella mano destra, con accanto una statua della Vergine
Maria, scrive: «Gradisci il qui unito mio
ritratto che ti mando per sempre meglio tenermi presente nelle tue preghiere:
la SS. Vergine, che mi è a fianco nel ritratto, mi sia sempre difesa e guida
per tutto il resto della mia vita» (23 agosto 1927).
Al
nipote Giovanni scrive: «E quando avrai
fatto del tuo meglio, tanto nello studio come nel resto, riponi tutto con piena
fiducia nel cuore del Signore e della nostra Madre Celeste senza altra
preoccupazione di un completo figliale abbandono in Loro, sicuro che tutto
andrà per il nostro meglio» (maggio 1929), e alla zia Maria: «Prega la nostra Madre Celeste che fissi più
intensamente anche su di me il suo purissimo sguardo onde rendermi per
l’avvenire un figlio più buono e più degno di Lei, che mi scuota e mi svegli
dal mio torpore, dalla mia pigrizia, dalla mia tiepidezza cronica e mi infiammi
di quella fiamma divina di carità che il suo Divin Figlio è venuto a portare
fra noi» (9 settembre 1929).
Anche
chi lo ha conosciuto o ha beneficiato del suo servizio, testimonia il suo
particolare amore a Maria, della quale esaltava la sua bontà, la sua purezza,
dimostrando, anche così, oltre che con la preghiera del Santo Rosario, la sua
figliale devozione. Inoltre, se durante la visita ai malati o lungo il viaggio,
sentiva il suono dell’Angelus di mezzogiorno, anche se si fosse trovato in una
pubblica piazza o in mezzo a un gruppo di persone, oppure avvertendo il suono
mentre era in bicicletta, si fermava, scendeva, scoprendosi il capo, tracciava
con molta calma un largo segno di Croce e, terminata la preghiera, riprendeva
la strada o la conversazione interrotta.
Una
devozione che prosegue quanto è religioso e che i confratelli vedono e
testimoniano, come i giovani aspiranti alla vita religiosa, accolti a Brescia,
ai quali diceva: «Avete lasciata la mamma, ma ne avete acquistata un’altra
assai più buona che non quella terrena»[11].
Inoltre, dopo la visita al Santissimo Sacramento in chiesa, andava anche a
pregare dinanzi all’altare della Madonna e poi, nel salire le scale per andare
in Noviziato si metteva a canticchiare a bassa voce le canzoni della Madonna,
come ad esempio Mira il tuo popolo o
il Lodate Maria. Non era una cosa
studiata, ma semplicemente un bisogno del suo cuore, in ogni momento, con
motivi d’amore per Dio[12].
Una
devozione sincera che manifestava nel desiderio di poter morire nel mese di
maggio, mese a lui tanto caro perché il mese dedicato a Maria. Lo testimonia la
sorella Margherita che lo assisteva a Milano, presso l’ospedale “San Giuseppe”,
dove era giunto il 18 aprile 1930 da Brescia, per l’aggravarsi della sua
malattia; ella dice: «Durante gli ultimi giorni della malattia, chiedeva
spesso: “Quand’è il primo maggio?”»[13].
Un desiderio che la Vergine Maria esaudì accompagnando questo suo devoto e
fedele figlio all’incontro con il suo Figlio Risorto nella sera del 1° maggio
1930.
Conclusione
A
conclusione e a sintesi del nostro percorso di approfondimento della
spiritualità di san Riccardo Pampuri, in questo anno giubilare, è significativo
quanto ha scritto fra Gabriele Russotto, che fu Postulatore Generale del nostro
Ordine, che con passione, entusiasmo e dedizione seguì la causa di
canonizzazione del Santo: «Aveva amato e
servito il Signore fin dai più teneri anni con fervore, naturalezza e
semplicità, edificando altamente i suoi compagni di collegio, d’università e
d’arme, i suoi colleghi, i suoi malati, i suoi confratelli e quanti lo
conobbero. L’idea-chiave della sua santità era stata di una limpidezza
cristallina: “Quello che vuole il Signore, lo voglio anch’io”; “Sarò fedele al
Signore in tutte le occasioni e circostanze delle quali è intessuta la vita di
ogni giorno: farò le piccole cose con grande amore”»[14].
Nell’immagine
stampata in occasione della morte di San Riccardo è riportata un’ulteriore
sublime sintesi della sua vita:
Come l’immagine soave di Fr. Riccardo dottor Pampuri
medico chirurgo dei Fatebenefratelli
così resti imperituro il profumo delle sue virtù non
comuni.
Umile e modesto visse la sua breve ma operosa
giornata
tutta nel lavoro e nella preghiera.
Spirito magnanimo in corpo tanto delicato dovunque passò
Spirito magnanimo in corpo tanto delicato dovunque passò
in seno alla famiglia adorata, nelle aule
universitarie
al letto degli Infermi, nelle file della Gioventù
Cattolica
in mezzo agli ammalati, ai confratelli
dell’Ordine Ospitaliero di S. Giovanni di Dio
diede prova luminosa di quanto possa il cuore umano
quando è traboccante di amore divino attinto e
alimentato
nelle lunghe veglie eucaristiche.
Mentre col desiderio lo rincorriamo in cielo
ne raccogliamo gli esempi, ne invochiamo la
protezione.